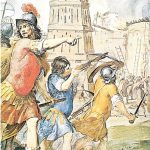Dialogo di due intellettuali intorno a Gerusalemme (sec. XIII ex.)
“Ciò che è consegnato solo alla memoria, con il passare del tempo viene facilmente dimenticato; perciò i filosofi e i sapienti del tempo antico hanno messo per iscritto le cose che consideravano utili ai posteri. Ma poiché nella cronaca del comune di Genova, composta da Caffaro, nobile cittadino genovese, nulla si rinviene sulla conquista di Gerusalemme, Antiochia, Tripoli e di molte altre città dell’oriente, alle quali presero parte più e più volte uomini di Genova con grande quantità di galee, di navi e di guerrieri e io, Jacopo Doria, consultando attentamente le scritture e i libri del defunto dominus Oberto Doria, mio nonno paterno, che certo conobbe perfettamente le cose antiche di questa città, trovata nei suoi scrigni un’antica scrittura stesa dal ricordato Caffaro, che conteneva la presa di Gerusalemme e di molte altre città, ne ho fatto trascrivere l’originale in questo libro, senza aggiungere né togliere nulla, affinché quelle gesta siano qui manifeste a chi leggerà.”1
L’autore di queste parole, Jacopo Doria, discendente di un’antica e potente casata, amica di imperatori, signora di terre in Liguria e in Sardegna, stirpe di marinai e di ammiragli, di consoli e di capitani del popolo, di guerrieri e mercanti sparsi dall’Europa al Mar Nero, è un attento esegeta delle vicende genovesi e uno dei due intellettuali più importanti in città alla fine del Duecento.2 L’altro, – l’arcivescovo Jacopo da Varagine – è un domenicano illustre e famoso per i suoi scritti.3 Pressoché coetanei (il Doria nasce nel ’34; il da Varagine tra il ’26 e il ’30), i due hanno trascorso la loro gioventù in modi completamente diversi. 1l primo, diplomatico e guerriero che non disdegna d’impegnarsi in attività di commercio tra Tunisi e Laiazzo, legato allo schieramento filoimperiale della famiglia, ne ha vissuto peripezie e glorie fino al momento in cui la sua stirpe – la più importante del tempo – ha riacquistato completamente il potere, acquisendo, dal 1270 e fino alla fine del secolo, un “capitanato del popolo” condiviso con un’altra fiera gente ghibellina – gli Spinola. Insieme le due famiglie hanno guidato le sorti genovesi, e cioè in quel momento le sorti del mondo. Per la verità erano stati anni di fuoco.
L’apoteosi angioina e l’azione del regno di Francia, con le loro opzioni mediterranee e complementari sul Regno siciliano, verso Bisanzio e verso Gerusalemme; con le loro strette relazioni con il papato di Roma e più ancora con il grande clan dei Fieschi, sostenuto dagli alleati Grimaldi, avevano reso più difficile, ma mai ostacolato l’intensa operatività economica genovese, che dopo il trattato di Ninfeo del 1261, aveva annodato i capi estremi delle rotte tra il Mar Nero e le Fiandre. Anche in vista di soluzioni alternative al franare delle colonie mediorientali, i genovesi avevano rafforzato il loro impegno nella ricerca di vie alternative verso l’Oriente. C’erano tuttavia anche altri problemi. Utile nel bilanciare la prepotenza angioina, come avevano dimostrato i Vespri siciliani del 1282, la Corona catalano-aragonese aveva ormai svelato la sua pericolosità ed era prossima allo scontro diretto con Genova. Continuava senza soste l’urto secolare con Pisa e con Venezia; anche se, nell’uno e nell’altro caso, prima la battaglia della Meloria (1284) e più tardi quella di Curzola (1298) avrebbero segnato qualche punto a favore di Genova. C’era, infine forse più pesante di tutto il resto la guerriglia cittadina, in parte fomentata dall’interno e in parte alimentata dall’esterno, dato che la scomparsa di Carlo d’Angiò nel 1285 non l’aveva comunque frenata.
Jacopo da Varagine, appartenente ad una famiglia legata allo schieramento opposto a quello del Doria, aveva vissuto a lungo lontano da Genova, impegnato in compiti e funzioni che ne avevano preparato l’ascesa nell’Ordine domenicano fino a consentirgli di raggiungere prima la carica di priore della grande provincia “lombarda”, che si estendeva a tutta l’Italia settentrionale e poi, dal 1283 al 1285, quella di rettore dell’Ordine. Dopo aver viaggiato in Europa e in Italia, rientrato a Genova, aveva assistito alle turbolenze di una città ancora colpita dalla scomunica per la sua scelta antiangioina, travagliata perfino da una congiura, patrocinata se non aizzata dal vicario apostolico Opizzo Fieschi nel gennaio dell’89. Erano quelli gli anni in cui si consumava definitivamente il destino delle colonie oltremarine. Nel 1289 era caduta Tripoli, nel 1291 anche Acri era perduta. Pur guardando sempre più verso Occidente, i genovesi avevano consolidato la loro presenza tra Cipro e il Mar Nero e stretto un’intesa con l’Egitto. L’abbandono di Acri ultimo brandello dell’antico Regno gerosolimitano aveva comunque segnato un punto di non ritorno. L’anno seguente Jacopo da Varagine, tra i possibili candidati alla cattedra arcivescovile già nel 1288, era diventato arcivescovo di Genova.
Grazie alla storia della sua famiglia, così legata all’espansione, Jacopo Doria era perfettamente consapevole che buona parte dei successi dei più antichi e potenti ceppi familiari genovesi aveva le sue radici nella vicenda oltremarina; lo aveva dimostrato per primo Caffaro, facendo principiare i suoi “Annali” dalla presa di Cesarea – tappa4 essenziale dell’affermazione del monopolio genovese in quelle zone. Ora, di fronte alle tristi vicende oltremarine, ancora una volta qualche voce si alzava a sostegno di una nuova “crociata”. Il Doria però non faceva parte di quel gruppo. Fratello di Oberto Doria vincitore alla Meloria e capitano del popolo insieme con Oberto Spinola – e di Lamba, destinato a trionfare a Curzola, dagli anni Settanta (con altri) e poi, dal 1280, da solo, Jacopo si era dedicato alla storia, occupandosi della stesura degli “Annali” ufficiali, operazione che certamente era resa più facile dal fatto che gli era stata affidata anche la cura dell’archivio del Comune. Ma l’annalista Jacopo Doria era qualcosa di più che un semplice raccoglitore di patrie memorie e di preziosi documenti. Era, invece, un, appassionato e attento “costruttore” della memoria. Due erano le vere passioni del Doria, a prima vista difficili da distinguere tra loro tanto egli stesso le confondeva, sovrapponendole e facendone un nodo inestricabile: l’amore per Genova e quello per la sua famiglia. Ma, nonostante le ardenti espressioni per la sua città, poste all’esordio e in calce agli Annali, di fatto la sua devozione è completamente consacrata alla grande famiglia alla quale appartiene. Non c’è pagina della sua storia, infatti, in cui non compaia il nome di un Doria. I Doria sono dappertutto, sulla terra e sul mare. Protagonisti di ogni decisione, ne vivono in prima persona le conseguenze, nel bene e nel male. C’ è un Doria a governare la Genova ghibellina di fine secolo; ma c’è pur sempre un Doria a capo della seconda flotta crociata di Luigi IX. Innumerevoli poi sono i Doria presenti alla Meloria e a Curzola; molti sono i Doria posti a controllo delle Riviere, della riottosa e difficile Corsica, della lontana – ma essenziale Calla. Grande parte del traffico mercantile avviene sulle loro galee, pronte a trasformarsi in vascelli guerrieri contro i pirati o ad operare esse stesse more piratico contro Pisani, Veneziani, Catalani. Appartengono ai Doria le case all’origine del pruno palazzo pubblico.
E’ vero dunque che, tra tutti gli “annalisti” genovesi, Jacopo è l’unico ad essere in tutto e per tutto omologo a Caffaro. Il primo storico di Genova aveva costruito il mito delle origini sulla figura di Guglielmo Embriaco – patriarca genovese di una famiglia-simbolo del sistema genovese al di qua e al di là del mare. Ora le cose erano cambiate: gli Embriaci – un tempo alleati – da molto tempo erano schierati sull’altro versante. I Doria, invece, dopo aver difeso accanitamente e tra molti travagli il loro ruolo, erano ormai dinastia dominante e Jacopo era il loro cantore, 1’aedo di un famiglia- simbolo. La sua, che, rispettando l’antico modello e mai inclinando a tentazioni monocratiche, nella proposta diarchica dei capuani del popolo Doria e Spinola, aveva innovato senza innovare. La storia di Genova continuava ad essere la storia dei genovesi; quella dei grandi gruppi familiari che avevano intrecciato i loro destini e le loro fortune con quelli del Comune. Anche per Jacopo Doria – come già era capitato a Caffaro – la celebrazione non poteva dunque che essere univoca.
Jacopo dedica largo spazio alle vicende ultime dell’oltremare. La sua collocazione familiare gli mette a disposizione una bella biblioteca (scripturas et libros aevi mei); ha curiosità antiquarie; ama i documenti, li raccoglie con pazienza, li allinea esaminandone le coerenze, ricreando preziose genealogie, che costellano i margini del Liber iurium da lui curato. Ila mente lucida e cultura notevole. Non sembra però uomo incline a nostalgie di alcun tipo, soprattutto quando si tratti diesperienze concluse. Come esponente del ceto dirigente di una città governata da uomini d’affari, è naturalmente portato o obbligato a guardare avanti. Celebra le capacità di Benedetto Zaccaria quando si tratti di vittorie alla Meloria o a Tarifa; ma il tono diventa freddo quando lo Zaccaria insiste nel voler contrapporsi al destino dell’ormai perente Tripoli; né si dilunga troppo sulla fine di Acri, pur segnalando il grande cruccio del papa e dei cardinali, dei re e dei baroni.
In realtà, tra tutte le notizie registrate, ce n’è una che già da sola – chiarisce bene in quale direzione stiano muovendosi gli interessi genovesi. Da tempo alcuni gruppi familiari operavano in area iberica, particolarmente in Andalusia e Portogallo. Nel 1291 – scrive Jacopo – Tedisio Doria, Ugolino e Vadino Vivaldi, con altri genovesi misero a punto un viaggio, che nessuno prima aveva osato affrontare. Armarono dunque due galee, le rifornirono di vettovaglie, acqua e tutto ciò che era necessario e con quelle − nel mese di maggio − si diressero verso lo stretto di Ceuta, per navigare − attraverso il mare Oceano – ad partes Indie e riportarne utili mercanzie. In quelle galee s’imbarcarono, infine, i due fratelli Vivaldi insieme a due frati minori; ciò colpì profondamente sia chi era presente sia chi ne udì solo parlare. Ma appena ebbero oltrepassato il luogo chiamato Gozora (e cioè pressappoco all’altezza delle Canarie), se ne perse notizia.5 È impossibile non cogliere la contemporaneità degli eventi. Strana coincidenza: nel mese di maggio cadeva Acri e quasi nello stesso momento si decideva di partire, affrontando un’altra, rischiosa via per arrivare in Oriente, evidentemente passando per l’Occidente. Jacopo non parla nè qui nè altrove di crociata; segnala invece la decisione di partire per un viaggio di esplorazione che ha per sua finalità esplicita il mercato. Anche se raccoglie con rispetto e con cura tutte le antiche memorie relative al grande passato genovese, declinato sul fondamentale contributo alla presa dei Gerusalemme e alla costruzione del regno gerosolimitano; anche se è uomo devoto c io sottolinea, per Jacopo Doria la storia è solo “il cammino dell’uomo nel mondo”. Il repechage delle vecchie testimonianze fa parte dunque soltanto dello scrupolo dello storico, impegnato a celebrare la sua città; il politico invece sembra volgere il suo sguardo ormai altrove.
Altri però sono assai meno tiepidi. Non solo non desistono dal tentare di rovesciare la diarchia, in compagnia dell’accanito vicario apostolico Opizzo Fieschi, sostenitore se non fomentatore di congiure; ma sono seriamente intenzionati a sostenere eventuali progetti di crociata, in buona armonia con gran parte delle genti occidentali, il regno di Francia e Venezia in primis, e in costante riferimento ai khanati mongoli. Tra i molti che a Genova si adoprano in tal senso, da Buscarello Ghisolfi a Galvano di Levanto (che stende il suo De recuperatione Terresancte dedicandolo a Filippo IV il Bello), c’ è ovviamente anche l’ “alter ego” di Jacopo Doria, l’arcivescovo Jacopo da Varagine.6
L’altro Jacopo è un uomo di chiesa, un domenicano energico, cresciuto nella fase costruttiva dell’ordine al quale appartiene. Ben formato negli studi e nella conoscenza del mondo, quando diventa finalmente − dopo varie vicissitudini arcivescovo di Genova − dal 1292 al 1298 (sei anni vissuti intensamente ), ha già steso la famosa Legenda aurea. Diventa il presule di uno dei centri politici ed economici più importanti del mondo proprio negli anni conclusivi della crisi mediorientale. Tocca inevitabilmente a lui il ruolo di contrappunto alla voce “laica” del Doria.
Anche Jacopo da Varagine dedica a Genova una storia. Ma la sua Chronica è assai diversa dagli Annali del Doria, con i quali ha un solo elemento in comune: celebrare la città e le sue glorie.7 Per adempiere al suo scopo, tuttavia, il da Varagine usa strumenti del tutto diversi da quelli usati dal Doria, decidendo di far vibrare altre corde, d’altronde ben dichiarate all’interno della complessa impalcatura, nella quale costringe il suo racconto. Per lui la storia della città va inserita nel disegno provvidenziale, che guida il cammino dell’uomo nel mondo. Perciò l’itinerario di Genova, destinata a diventare “capitale della cristianità”, comincia fin da tempi lontanissimi, dipanandosi in scansioni sicure e progressive fino all’attualità. Pure l’arcivescovo conosce bene le questioni politiche ed economiche; sa che esistono le lotte di fazione e i problemi nel Mediterraneo occidentale e orientale; che non è facile recuperare ciò che si è forse definitivamente perduto. Ma per lui il nome di Gerusalemme non è soltanto l’alto simbolo di una storia gloriosa, seppur tramontata. Per Jacopo da Varagine, Gerusalemme è e resta la città del Santo Sepolcro. Guerrieri-mercanti senza paura, sempre pronti a battersi gloriosamente contro l’impero, contro Pisa e contro Venezia, i genovesi, proprio combattendo nella prima crociata come “cavalieri di Dio” e liberando Gerusalemme, hanno consentito alla loro città di raggiungere lo status perfectionis, che rappresenta la tappa definitiva della sua crescita e dei suoi successi. Una vicenda cominciata in tempi lontani, cresciuta con la conversione al Cristianesimo, celebrata nell’antico, ma sempre vivo ruolo antisaraceno, sancita dalla crociata, culminata, infine, nell’erezione in sede arcivescovile. Per il pio domenicano, dunque quel che ha scritto Caffaro è prezioso, e ciò che si recupera non é solo testimonianza dei successi genovesi o nostalgica riflessione sul passato. E’ soprattutto prova di una perfetta identità cristiana, che è tutt’uno con l’identità genovese. Uomo di pace in patria, Jacopo lo è assai meno quando il suo sguardo si volge al mondo. Nelle dodici parti della sua opera, – un vero manuale di teologia politica comunale – domina la celebrazione della città come sede privilegiata di realizzazione del “bonum commune”; dove mercanti-guerrieri che sono perfetti cristiani, sanno essere anche buoni cittadini. Ecco dunque tornare un appropriato recupero del passato. Splende di nuovo l’astro di Guglielmo Embriaco, celebrato da Gallalo come conquistatore di Cesarea e ora – proprio secondo la Liberatio ritrovata da Jacopo Doria anche come eroe nella presa di Gerusalemme. E d’altra parte non è forse vero che ancora in quel momento i suoi discendenti – unici tra tutti gli Occidentali tengono ancora Gibelletto? Nulla regge il confronto con l’eroe per eccellenza della storia genovese. E su di lui, primo nella storiografia locale, Jacopo compie un’operazione ardita, legando al suo nome il recupero del “sacro catino”, qui presentato − sia pure tra molte prudenze − come un possibile “graal”. Caffaro non ne aveva parlato; ne aveva invece trattato, nella storia dedicata all’oltremare, l’arcivescovo Guglielmo di Tiro; e, tra il 1287 e 1’88, lo aveva visitato anche il monaco nestoriano Rabban Sauma, in viaggio diplomatico verso le monarchie europee.8 Ma non basta. Nell’ opera di ricostruzione della memoria, che vuole essere un richiamo ai suoi “cavalieri di Dio”, Jacopo recupera anche la storia delle più importanti reliquie genovesi; spiccano tra esse le ceneri di San Giovanni, legate alle prime vicende oltremarine, alle quali l’arcivescovo dedica pure un’ apposita operetta.9 Il passato dunque non è solo aristocrazia delle origini, memoria di glorie perdute, nostalgia. Per il tenace e battagliero arcivescovo esso è invece gloria viva; in qualche misura − ma non ci è dato sapere fino a che punto − è stimolo e sostegno a scelte di guerra “giusta”, come Jacopo stesso scrive.10
Ma la storia segue il suo corso. Nell’anno che precede la sua morte, l’arcivescovo dovrà addirittura giungere a interporre la sua persona tra chi contende per il potere, nel tentativo di dirimere le fiere lotte che si sono riaccese in città. L’altro Jacopo aveva chiuso le sue battaglie intellettuali ben prima di lui; quando, adducendo ragioni di età e cattiva salute, aveva concluso e presentato ufficialmente i suoi Annali. Suo fratello Oberto si era appena ritirato a vita privata, lasciando al figlio Corrado il compito di condurre a termine il mandato. Fosche nubi si stanno addensando su Genova; e la riconquista di Gerusalemme appare di nuovo lontana.
1 Iacobi Aurie, Annales, in Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, a cura di L.T. Belgrano – C. Imperiale di Sant’Angelo, Fonti per la storia di Italia, 11-14 bis (Roma, 1890-1919), V, pp. 3-176. Per le operette relative: Cafari De liberatione civitatum Orientis liber, in Annali genovesi di Caffaro e de’suoi continuatori, a cura di L.T. Belgrano e – C. Imperiale di Sant’Angelo, Fonti per la Storia d’Italia, 11-14 bis (Roma, 1890-1919), I, pp. 98-124; Regni Hyerosolimitani brevis istoria, ibid., pp. 127-48. Per gli aspetti generali: C. Imperiale di Sant’Angelo, Jacopo d’Oria e i suoi Annali (Venezia, 1930); R.S. Lopez, Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante nella Genova del Duecento (Messina- Milano, 1933).
2 G. Airaldi, Andrea Doria (Roma 2015).
3 G. Airaldi, Jacopo da Varagine tra santi e mercanti (Milano, 1988).
4 G. Airaldi, Memoria e memorie di un cavaliere: Caffaro di Genova, «Crusades», pp. 25-40; Eadem, Blu come il mare: Guglielmo e la saga degli Embriaci, Genova, 2006.
5 Sui caratteri del viaggio compiuto da Ugolino e Vadino Vivaldi con le galee “Allegranza” e “Sant’Antonio”, armate da Tedisio Doria cfr. B. Z. Kedar, Merchants in crisis: Genoese and Venetian men of Affaire and the Fourteenth Century Depression (New Haven 1976), pp. 174-77.
6 G. Airaldi, Guerrieri e mercanti (Torino, 2004), pp. 55-105.
7 Iacopo da Varagine e la sua cronaca di Genova dalle origini al MCCXCVII, a cura di G. Monleone, Fonti per la storia d’Italia (Roma, 1941), pp. 84-86.
8 G. Airaldi, Guerrieri cit., pp. 19-36.
9 Iacobi de Voragine, Legenda translationis beatissimi Joannis Baptistae. Cfr. L.T. Belgrano, Due opuscoli di Jacopo da Varagine trascritti dal socio Amedeo Vigna, X ( 1876), pp.56-87.
10 Su questo tema B. Z. Kedar, Crusades and Mission: European Approaches toward the Muslims (Princeton, 1984).