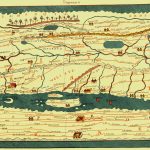Liguria, la progressiva definizione del territorio regionale: dalle Alpes Cottiae alla Provincia Maritima Italorum
La Liguria, una regione tra Alpi e Mediterraneo
In un articolo pubblicato oltre cinquant’anni fa Geo Pistarino aveva segnalato il problema del nome della Liguria: « […] un nome arcaico, tra i più antichi d’Italia, sopravvissuto ad una lunga avventura, che ha conosciuto vicende alterne, momenti oscuri e periodi di fervore culturale. E tuttavia, per quanto possa sembrare strano, non esiste una Liguria come designazione ufficiale d’una struttura politica, giuridica, amministrativa, religiosa, che corrisponda integralmente all’odierna regione dalla notte dei tempi sino all’età moderna».
Lo studioso evidenziava poi le oscillazioni della forma della Liguria, sulla base delle due tendenze, l’una orizzontale in conformità con la linea di costa, l’altra verticale proiettata verso l’interno, e la conseguente dialettica tra due strutture contrapposte, la Maritima bizantina e le Marche di Berengario marchese di Ivrea, con finalità diverse legate alle dinamiche del mare la prima, a quelle della terra la seconda1.
Nell’evoluzione dalla Liguria romana a quella medievale una fase particolarmente critica è quella tra la fine del V secolo e l’invasione longobarda dell’Italia nel secolo successivo, quando si succedettero rapide fluttuazioni dei confini regionali a causa degli eventi militari. Le fonti relative a questo periodo sono state ampiamente discusse in ragione delle contraddizioni, delle diverse possibilità interpretative e della loro attendibilità.
La Liguria di Iordanes e di Procopio di Cesarea
Nelle fonti tardo-antiche si colgono incertezze sul territorio occupato dalla Liguria, il nome della regione e il suo status amministrativo che in effetti furono soggetti a diversi cambiamenti. Certamente Diocleziano trasformò l’antica prefettura alpina delle Alpes Cottiae in provincia e la annesse alla diocesi italiana2. Sembra che questo imperatore ne avesse accresciuto l’estensione verso la pianura, anche se la Notitia Dignitatum, fonte probabilmente redatta almeno per la pars Occidentis dell’impero a Costantinopoli nel V secolo3, non riporta tale cambiamento. Lo storico Iordanes, tuttavia, autore del VI secolo, riferendosi però alle operazioni militari di Stilicone (IV-V secolo), vi include la città di Pollenzo, mentre Procopio di Cesarea scrive «Nelle Alpi che separano i Galli dai Liguri, dette dai Romani Alpi Cozie, vi sono molte fortezze…»4, lasciando intendere una conformazione molto alpina della regione.
Nella seconda metà del VI secolo Marcellino Comes, contemporaneo di Procopio e di Iordanes, fornisce una descrizione della Liguria conforme a quella del IV secolo. In un passaggio del suo Chronicon indica Genova come una città della costa tirrenica appartenente all’assetto politico della Liguria: «Theudibertus Francorum rex cum magno exercitu adueniens Liguriam totamque depraedat Aemiliam. Genuam oppidum in litus Tyrrheni maris situm euertit ac praedat. Exercitu dehinc suo morbo laboranti ut subueniat, paciscens cum Belisario ad Gallias reuertitur »5.
Le Alpes Cottiae, un problema di datazione: il Laterculus di Polemio Silvio fonte di Paolo Diacono
Nella seconda metà del VI secolo la situazione amministrativa della regione probabilmente cambiò proprio in relazione alle Alpes Cottiae. In un passo famoso l’autore dell’Historia Langobardorum, Paolo Diacono, descrive la provincia in questi termini delineando per primo il rapporto tra le Alpes Cottiae, le Alpes Appenninae e la Liguria: «La seconda provincia (dell’Italia) ha nome Liguria, dai legumi che vi si raccolgono di cui essa è ricca. In essa vi si trovano Milano e Ticino, che con altro nome è detta Pavia. Essa si estende fino ai confini delle Gallie […]. La quinta provincia si chiama Alpi Cozie; queste sono così dette dal re Cozio dai tempi di Nerone. Questa provincia si estende dalla Liguria fino al mare Tirreno, secondo la direzione delle Alpi stesse, e confina ad occidente con le Gallie. In essa vi sono le città di Acqui, dove si trovano delle acque calde, Tortona, Bobbio col monastero, Genova e Savona […].Quindi la nona provincia è costituita dalle Alpi Appennine, che hanno origine dove finiscono le Alpi Cozie […]. Vi sono quelli che dicono le Alpi Cozie e quelle Appennine sono un’unica provincia, ma lo nega (Aurelio) Vittore definendo nella sua Storia le Alpi Cozie una provincia a parte. Quindi la decima provincia, l’Emilia, inizia dalla Liguria e occupa la regione fra le Alpi Appennine ed il corso del Po fino a Ravenna»6.
L’attenzione degli studiosi si è rivolta alle fonti cui avrebbe attinto lo storico dei Longobardi, ovvero in particolare il Laterculus di Polemio Silvio risalente al 448-449, mentre l’interpolazione che qui interessa sarebbe successiva7. Se ne deduce che ad un certo momento le Alpes Cottiae si estesero sino a comprendere la costa ligure come indica l’espressione in quibus est Genua, presente nella sola tradizione del Laterculus della Cattedrale di Spira, il cui originale è andato perduto privandoci della possibilità di una datazione. Secondo le indagini più recenti questa modifica amministrativa risalirebbe alla seconda metà del VI secolo, successivamente al termine della guerra gotica e in corrispondenza o, meglio, a seguito dell’invasione longobarda e dopo che la provincia Alpes Cottiae avrebbe perso completamente l’area montana assorbita dal regno dei Franchi nel 575-5778. A questa datazione riconducono alcune evidenze note agli studiosi che si sono occupati dell’argomento.
Una conferma sulla datazione proviene da Giovanni Diacono, autore di una biografia di Gregorio Magno nel IX secolo: l’autore afferma che il patrimonio della Chiesa nella provincia, identificata dal Febre col territorio delle Alpes Cottiae, era già costituito ai tempi del celebre papa, dunque tra VI e VII secolo9. Il Liber Pontificalis inoltre asserisce che il re longobardo Ariperto restituì il patrimonio a suo tempo confiscato alla chiesa all’inizio del VII secolo10.i
Era stata dunque creata una circoscrizione amministrativa abbastanza importante e duratura da generare una “memoria patrimoniale” nella Chiesa di Roma. Tale nuovo assetto del territorio garantiva una linea difensiva continua, suddivisa in due parti, Alpes Cottiae e Alpes Appenninae, per creare un’organizzazione più snella, rivolta a contenere l’invasione longobarda dilagata nella Pianura Padana.
Nel 584 la costituzione dell’Esarcato di Italia probabilmente non interferì sull’assetto provinciale, che secondo l’interpretazione più recente riguarderebbe il vertice dell’organizzazione ai fini di garantire un comando autocratico, direttamente dipendente dall’imperatore, capace di gestire la situazione militare e di negoziare con pieni poteri11. Inoltre La Descriptio orbis Romani di Giorgio di Cipro, un testo tramandato insieme alle Notitiae episcopatuum propone una nuova articolazione dell’Italia del tempo, strutturata in cinque regioni: Urbicaria, Annonaria, Kampanias, Kalabrias tôn Brittiôn, Aimilias12. L’intepretazione di P. M. Conti, che ricollega questi assetti ad una riforma messa in atto sotto Tiberio II (578-582), è stata messa in discussione sulla base di analisi storiche, filologiche e culturali13.
Insomma, né la nascita dell’Esarcato né le presunte Eparchie del Ciprio ci consentono di datare efficacemente la nascita delle nostre Alpes Cottie. È certo invece che nel VII secolo mutarono le circoscrizioni amministrative e soprattutto gli assetti istituzionali urbani, con la nascita di figure che andavano a sommare potere militare e potere civile (dux, magister militum)14. Il tutto appare comunque molto incerto e disomogeneo15.
Una fonte trascurata: Agazia di Mirina
Può offrire un contributo al problema della datazione delle Alpes Cottiae di Paolo Diacono un passo degli Historiarum Libri Quinque di Agazia, autore greco del VI secolo, che si sofferma sulla scorreria dei Franchi, avvenuta nel 554, con questa osservazione: «E dunque (i Franchi) se ne andavano subito, avendo lasciato alla loro destra il golfo dello Ionio e tutta la sabbiosa via costiera, seguendo il percorso ai piedi del monte Appennino. Giunti così direttamente in Emilia e nelle Alpi Cozie, a stento potevano attraversare il Po»16.
Ciò che descrive Agazia è abbastanza chiaro: i Franchi, risalendo l’Italia e lasciandosi alla propria destra un mare che lo storico denomina Ionio ma che corrisponde all’attuale Adriatico, ad un certo punto si trovano, ai piedi dell’Appennino, ad un bivio: alcuni di loro vanno in Emilia, altri vanno nelle Alpes Cottie, in questo passo evidentemente considerate come una regione confinante con la prima, ai piedi dell’Appennino, e a sud del Po, fiume che poi essi attraversano non senza difficoltà. Mi pare che ci siano tutte le condizioni per poter dire che questo passo descriva le Alpes Cottie esattamente come la regione indicata da Paolo Diacono.
La costituzione delle Alpes Cottie non poté certo avvenire nel corso della guerra o immediatamente dopo, ma si può ipotizzare che lo storico bizantino nel descrivere l’episodio del 554 avesse in mente un assetto istituzionale successivo e che si possa precisare la forbice cronologica della nuova sistemazione indicando come terminus post quem il 568 o più precisamente, in considerazione anche delle osservazioni sopraindicate e di quelle più recenti di Dallas DeForest sulla datazione delle Storie, una data alla fine degli anni Settanta17, ma non posteriore al 582/584 quando lo storico moriva. Agazia avrebbe dunque potuto riferirsi, forse per una svista, al nuovo assetto della regione scrivendo di fatti avvenuti precedentemente solo in questo arco di tempo, non prima e non dopo.
Del resto, la concezione tradizionale della Liguria intesa come provincia transpadana e conforme al contesto cronologico di riferimento è presente nel testo di Agazia, come si rileva dal seguente passo relativo alle vicende legate all’invasione franco-alemanna dell’Italia del 553 d.C.: «I Goti che abitavano l’Emilia, la Liguria e le regioni vicine, che precedentemente, più per timore che per buona disposizione, avevano stipulato in modo infido e forzato una pace e un’alleanza militare (coi Bizantini), fattisi coraggio, infransero apertamente la tregua e subito si recarono dai barbari (i Franchi), che erano loro simili per la condotta di vita»18.
La Provincia Maritima Italorum: ultimo assetto della Liguria bizantina
Nel 594 d.C. Agilulfo sfondò il confine in Lunigiana e creò un corridoio permanente di comunicazione tra l’entroterra padano e l’Italia centrale, aprendosi la via per Roma sulla quale, infatti, compì un’incursione. È in quel momento che venne rotto l’asse longitudinale tra le Alpes Cottiae e le Appenninae, e la “nostra” Liguria, si trovò, di fatto, isolata via terra. È possibile che in quel momento le Alpes Cottiae siano state trasformate in una nuova entità amministrativa.
Alla metà del VII secolo, un anonimo chierico di Ravenna compose un’opera secondo alcuni tratta dalla Tabula Peutingeriana, chiamata Cosmographia, che ebbe un larghissimo successo nel medioevo soprattutto perché venne ampiamente ripresa nel XII secolo da un altro autore, Guido da Pisa19. Descrivendo tutto il mondo conosciuto, al Libro IV, capitolo 29, l’Anonimo affronta l’Italia. Essa viene divisa in diciotto province, ecco il passo che riguarda la nostra attuale Liguria:
«L’Italia possiede diciotto famosissime province, cioè la Liguria, la provincia delle Venezie, l’Istria quindi di seguito, lungo la strada imperiale vicina alla sopraddetta provincia della Liguria Transpadana vi è la provincia chiamata Emilia […], quindi la Provincia Maritima Italorum, detta di Luni, di Ventimiglia e di altre città»20.
A differenza di quanto possiamo riscontrare per le Alpes Cottiae, la Provincia Maritima Italorum è riscontrabile nel solo testo del Ravennate. E’ possibile che restituisca una circoscrizione amministrativa realmente esistita, anche se essa contraddice quella naturale concezione della “Liguria” come area geografica fortemente integrata con il retroterra padano, quale era stata prima e come tornerà ad essere dopo. Solo l’espansionismo genovese del secondo medioevo riproporrà un’area politicamente coesa limitata all’arco tirrenico come fu la Maritima.
Nell’ottica dell’integrazione politico-territoriale, la Maritima rappresenta l’ultima manifestazione della Liguria antica, e l’ingresso della Liguria nel Medioevo. Con la conquista longobarda l’effimera Liguria costiera ebbe fine, e la nostra regione passò dal sistema di integrazione bizantino ad altri due, nel giro di cento cinquanta anni: il regno longobardo prima, l’impero carolingio poi. Avvenne allora ciò che era avvenuto ai tempi dei romani, con l’integrazione delle tribù indigene dell’arco appenninico in un grande impero.
Da qui si riparte per una storia tutta nuova. Le parole con cui le fonti mettono fine a quella vecchia sono estremamente scarne, ma le riportiamo per l’importanza del passaggio, e per far notare che, per altro, non fanno alcun riferimento alla Maritima:
«Rotari con un esercito devasta, distrugge e brucia, dopo averle staccate dall’Impero (bizantino), le città di Genova marittima, Albenga, Varigotti, Savona, Oderzo e Luni; rapina, spoglia e condanna alla prigionia le popolazioni. Abbattendo al suolo le mura delle sopraddette città, ordinò che queste stesse città fossero chiamate villa»21.
«E dopo di lui (Arioaldo) regnò Rotari, Arodo di stirpe, che distrusse le città e i castelli dei Romani situati sulla costa da Luni fino alla terra dei Franchi, così come Oderzo ad Oriente [...]»22.
«Pertanto il re Rotari conquistò tutte le città romane site sulla riva del mare da Luni, città della Tuscia, fino ai confini dei Franchi»23.
Note
1 G. Pistarino, La capitale del Mediterraneo, Bordighera 1993, pp. 5-33, la citazione a p. 9.
2 R. Pavoni, Liguria medievale. Da provincia romana a stato regionale, Genova 1992, p. 80.
3 S. Cosentino, Storia dell’Italia bizantina (VI-XII secolo da Giustiniano ai Normanni), Bologna 2008, p. 21.
4 Procopio, Bellum Gothicum, II, 28, 28.
5 Marcellinus Comes, Chronicon, anno 539.
6 Paulus, Historia Langobardorum, edd. L. Bethmann – G. Weitz, in MGH, Scriptorum Rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX, Hannover 1878, II, 15, 16, 18. La traduzione, come in seguito le altre salvo diversa indicazione, è tratta da G. Gaggero, Fontes Ligurum et Liguriae Antiquae, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n. s. XVI (1976).
7 Pavoni, Liguria cit., pp. 55-81. Cfr. anche P. Febre, Le patrimoine de l’Eglise romaine dans les Alpes Cottiennes, in«Melanges d’archeologie et d’histoire», 4 (1884), pp. 383-420.
8 Pavoni, Liguria cit., p. 91.
9 Sancti Gregorii Magni Vita, in J. P. Migne, Patrologia Latina, 75, Paris 1849, II, 53.
10 L. Duchesne, Liber Pontificalis, I, Paris 1886, p. 312. Cfr. Febre Le patrimoine cit., p. 385.
11 Gli studi più recenti sono critici riguardo alla costituzione di una configurazione amministrativa vera e propria, limitandosi ad attribuire alla figura dell’esarca un ruolo politico e militare: cfr. Cosentino, Storia cit., p. 22 e, soprattutto, pp. 136-137; G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, Bologna 2018, p. 81.
12 H. Gelzer, Georgii Cypri Descriptio orbis Romani, Lipsia 1890, pp. 28-32.
13 In riferimento a P.M. Conti, L’Italia bizantina nella «Descriptio orbis romani» di Giorgio Ciprio, in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini”», XL (1975), pp. 38-40, cfr. Cosentino, Storia cit., p. 21.
14 Ravegnani, I Bizantini cit., p. 82.
15 Cosentino, Storia cit., p. 22.
16 Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque, ed. R. Keydall, Berlin 1967, p. 43 (II, 3,2).
17 D. DeForest, Agathias on Italy, Italians and the Gothic War , in «Estudios medievales», 8 (2020), pp. 61-81.
18 Agathiae Myrinaei cit., p.29 (I, 15,7).
19 Cosentino, Storia cit., pp. 24-25.
20M. Pinter-G. Parthey, Anonymi Ravennatis Cosmographia et Guidonis Geographica, Berlin 1860, pp. 246-249.
21Pseudo Fredegario, Chronicon, ed. B. Krusch, MGH, Scriptorum Rerum Merovingicarum, II, Hannover 1888, p. 156 (IV, 71).
22 Paulus, Origo Gentis Langobardorum, in M.G.H., Scriptorum rerum Langobardicarum cit., pp. 1-6.
23 Paulus, Historia cit., p. 135 (IV, 45).
Bibliografia
AA.VV., Sant’Antonino, un insediamento fortificato nella Liguria bizantina, Bordighera 2001.
G. Airaldi, Genova e la Liguria nel medioevo, Torino 1986.
G. Airaldi, Storia della Liguria. Dalle origini al 643, Genova 2009.
G. Airaldi, Storia della Liguria. Dal 643 al 1492, Genova 2009.
G. Airaldi, S. Origone, P. Stringa, C. Varaldo, Storie e storici del Mediterraneo medievale, a c. di S. Origone, Genova 2020.
T. S. Brown, Gentlemen and Officers: Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554–800, London 1984.
S. Cosentino, Storia dell’Italia bizantina (VI-XII secolo da Giustiniano ai Normanni), Bologna 2008.
P. Febre, Le patrimoine de l’Eglise romaine dans les Alpes Cottiennes, in « Mélanges d’archéologie et d’histoire», tome 4, 1884, pp. 383-420.
S. Origone, Bisanzio e Genova, Genova 1992.
S. Origone, Le signore del mare. Una storia del Mediterraneo medievale, Genova 2020.
S. Origone, Liguria bizantina: 538 – 643, in ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΥΣ, Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag, a cura di C. Scholz – G. Makris, Munchen-Leipzig 2000.
R. Pavoni, La conquista longobarda della Liguria, in «Atti dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere», 41 (1984), pp. 3-16.
R. Pavoni, Liguria medievale, da provincia romana a stato regionale, Genova 1992.
G. Petracco, La Descriptio Orbis Romani di Giorgio Ciprio, Alessandria 2018.
G. Pistarino, La capitale del Mediterraneo, Bordighera 1993.
V. Polonio, Da provincia a signora del mare. Secoli VI – XIII, in D. Puncuh, Storia di Genova: Mediterraneo, Europa, Atlantico, Genova 2003.
G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, Bologna 2018.